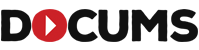Cos’è il Fascismo:
Nella seconda metà degli anni ‘20, quando in Germania il Nazismo era ancora una forza marginale. In Italia lo Stato totalitario era già una realtà consolidata nelle sue strutture giuridiche. Ben riconoscibile nelle sue manifestazioni esteriori: le adunate di cittadini in uniforme, le campagne propagandistiche orchestrate dall’autorità, l’amplificazione dell’immagine. Della parola del capo, oggetto di un vero e proprio culto.
Caratteristiche Essenziale:
La caratteristica essenziale del regime fascista era la sovrapposizione di due strutture e di due gerarchie parallele: quella dello Stato, che aveva conservato l’impalcatura esterna del vecchio stato monarchico, e quella del partito con le sue numerose ramificazioni. Il punto di congiunzione fra le due strutture era rappresentato dal Gran consiglio del fascismo, organo di partito investito anche di importantissime funzioni costituzionali. Al di sopra di tutti si esercitava incontrastato il potere di Mussolini, che riuniva in sé la qualifica di capo del governo e quella di duce del fascismo. Contrariamente a quanto sarebbe accaduto in altri regimi totalitari, nel fascismo italiano l’apparato dello stato ebbe fin dall’inizio. Per esplicita scelta di Mussolini, una netta preponderanza sulla macchina del partito.
Per trasmettere la sua volontà dal centro alla periferia, per esempio, Mussolini si servì del tradizionale strumento dei prefetti assai più che degli organi locali del Pnf.
A controllare l’ordine pubblico e a reprimere il dissenso con la forza provvedeva la polizia di Stato. La Milizia era confinata a una funzione poco più che decorativa di corpo “ausiliario”, senza nessun paragone con quello che sarebbe stato il ruolo svolto in Germania prima dalle SA e poi dalle SS.
L’Italia dopo la guerra:
Nonostante l’Italia fosse tra i paesi vincitori del conflitto, l’esito della guerra portò grandi delusioni. Inoltre da un lato l’opinione pubblica riteneva che il paese fosse stato sfavorito dai trattati di pace, dall’altro la società, e in particolare i reduci, che faticavano a reinserirsi in essa, vivevano i problemi post-bellici in misura non minore rispetto alle altre nazioni.
Il biennio rosso:
Gli anni 1919-1921 fecero registrare segnali preoccupanti: un aumento dei fenomeni di illegalità politica, motivati dall’eversione nazionalista (vedi d’Annunzio a Fiume) e anche dalla protesta del movimento operaio, che cercò in qualche caso di trasferire il potere nelle fabbriche agli operai (seguendo l’esempio russo), ma soprattutto tentò di far valere i propri diritti, ormai sempre più schiacciati dai grandi imprenditori. Le istanze socialiste terrorizzarono il capitalismo e la grande borghesia, che finanziò le azioni repressive delle squadre fasciste.
Il colpo di stato del 1922:
Il fascismo fu un movimento il cui programma nei primi anni non era affatto chiaro: in esso coesistevano nazionalismo, ideali conservatori, istanze libertarie, anticomunismo, pura e semplice violenza. Grazie all’appoggio di vasti settori del capitalismo, del re, di molti cattolici, e alla debolezza dei governi liberali, il capo del movimento, Benito Mussolini, poté proporsi come uomo d’ordine, ed ottenere la carica di capo del Governo dal Re.
Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti:
Il fascismo non fu affatto un fenomeno passeggero, come molti speravano, ma si insediò sempre più stabilmente al potere. Le elezioni del 1924, sono segnate da brogli e irregolarità evidentissime, sancirono l’inizio del regime. Matteotti fu eliminato fisicamente come socialista e osò denunciare le violenze dei fascisti.
La fascistizzazione dello stato italiano:
Mussolini a metà degli anni Venti aveva ormai campo libero per trasformare lo Stato in senso fascista, con le “leggi fascistissime”. Nel 1925 partiti e sindacati vennero aboliti, le garanzie costituzionali sospese.
La normalizzazione e la legittimazione del fascismo:
A seguito della disgregazione del blocco liberale, il fascismo divenne di fatto il nuovo polo di aggregazione dei ceti conservatori italiani; la legittimazione completa del regime venne con i Patti lateranensi, che posero fine alla controversia tra Italia e Chiesa cattolica.
La politica economica del fascismo e il corporativismo:
Nei primi anni la politica economica del fascismo fu liberista e assecondò gli interessi dei grandi capitalisti; si riuscì a mantenere il valore della lira a quota 90 contro il dollaro, ma a spese dei salari dei lavoratori. I fascisti difendevano un’economia corporativa, in cui i contrasti di classe erano superati in nome del bene supremo dello Stato. La crisi internazionale del 1929 colpì anche l’Italia, rendendo necessario l’intervento dello Stato e la creazione di un’economia mista di salvataggio (nascita dell’IMI e dell’IRI).
La fascistizzazione delle coscienze:
Il fascismo fu il primo regime totalitario: lo Stato fascista pretendeva di conoscere e organizzare ogni aspetto della vita dei cittadini. In questa linea ci furono la fascistizzazione dei mass media, perfettamente allineati al regime, la creazione di una cultura fascista, la riforma della scuola, la creazione di organizzazioni ricreative fasciste per i giovani e i bambini.
La politica estera del fascismo negli anni Trenta:
Nei primi anni del regime Mussolini seguì una linea prudente e conciliante verso le nazioni occidentali; l’isolamento indusse il fascismo ad avvicinarsi alla Germania nazista, di cui subì sempre più l’influenza, come è dimostrato dalle leggi razziali anti-ebraiche emanate nel 1938.